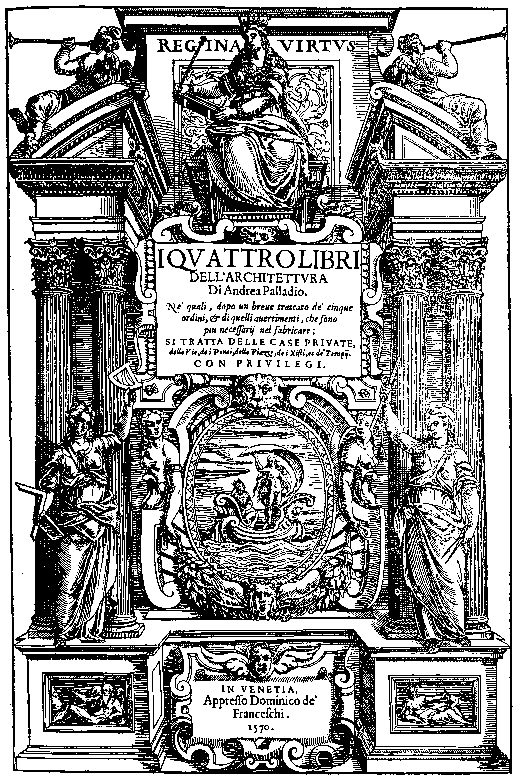
AL MOLTO MAGNIFICO
MIO SIGNOR OSSERVANDISSIMO,
IL SIGNOR CONTE GIACOMO
ANGARANNO
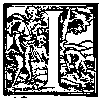 MERITI amplisimi della uoſtra infinita corteſia (molto Magnifico Signor mio) ſono per li molti Singolarisſimi beneficij, che con perpetua liberalità già tanti, e tanti anni m'hauete fatto continuamente; in tal modo creſciuti, & di numero, & di grandezza: che s'io non cercasſi di rendermiui grato, almeno co'l dimoſtrarmene ſempre ricordeuole; ſon certisſimo, che porterei pericolo di eſſer notato, e tenuto da tutti per diſcorteſe, e per ingrato. E perche fin dalla mia giouanezza mi ſon grandemente dilettato delle coſe di Architettura, onde non ſolamente ho riuolto con faticoſo ſtudio di molt'anni i libri di coloro, che con abbondante felicità d'ingegno hanno arricchito d'eccellentisſimi precetti queſta ſcientia nobilisſima: ma mi ſon traſferito ancora ſpeſſe uolte in Roma, & in altri luoghi d'Italia, e fuori; doue con gli occhi proprij ho ueduto, & con le proprie mani miſurato i fragmenti di molti edificij antichi: iquali ſendo reſtati in piedi fino à noſtri tempi con marauiglioſo ſpettacolo di Barbara crudeltà; rendono anco nelle grandisſime ruine loro chiaro, & illuſtre teſtimonio della uirtù, & della grandezza Romana: in modo che ritrouandomi io grandemente eſercitato, & infiammato ne gli ottimi ſtudij di queſta qualità di Virtù, & hauendo con gran ſperanza meſſo in lei tutti i miei penſieri; mi poſi anco all'impreſa di ſcriuer gli auertimenti neceſſarij, che ſi deuono oſſeruare da tutti i belli ingegni, che ſono deſideroſi di edificar bene, & leggiadramente; & oltra di ciò di moſtrar in diſegno molte di quelle fabriche, che da me ſono ſtate in diuerſi luoghi ordinate; & tutti quelli antichi edificij, c'ho fin'hora ueduti: Però (non già per pagar alcuno degli oblighi infiniti, c'ho contratto con la uoſtra gentilezza, per laquale uoi ſete ſopra ogn'altro amato celebrato, & reputato degno d'ogni altisſimo grado d'honore; ma per dimoſtrarui ſolamente con honorato teſtimonio delle fatiche mie alcun ſegno del mio animo grato, & ricordeuole della grandezza del uoſtro ualore) ui faccio hora un dono di queſti due miei primi libri, oue io tratto delle caſe priuate; ne' quali confeſſo hauer hauuto i Cieli tanto fauoreuoli, che hauendoli io in molte grandi mie occupationi, che quaſi del continuo mi tengono il corpo, e l'animo oppreſſo, & dopo alcune mie non picciole infirmità, finalmente ridotti à quella perfettione, che per me s'è potuta; & hauendo approuato quel tanto, che in lor ſi contiene con lunga eſperienza, ardiſco di dire, d'hauer forſe dato tanto di lume alle coſe di Architettura in queſta parte, che coloro, che dopo me uerranno; potranno con l'eſempio mio, eſercitando l'acutezza de i lor chiari ingegni; ridurre con molta facilità la magnificenza de gli edificij loro alla uera bellezza, e leggiadria de gli antichi. Pregoui dunque Illuſtre mio Signore, che uoi, facendo un'atto degno della uoſtra virtù; uogliate in premio dell'affettion, ch'io ui porto, degnarui di riceuere in dono, & con allegro uolto fauorire queſta prima parte dell'opera mia, che fu già con nobil penſiero incominciata ſotto i felicisſimi auſpicij uoſtri; laquale, come primitie del mio ingegno, ui dedico; & di eſſer contento, che hora, che con tanto fauor della uoſtra liberalità ella ſi ritroua finita; poſſa anco andare con lieto augurio nella luce del Mondo, da ogni parte illuſtrata dal chiarisſimo lume del nome uoſtro; poi che io ſon ſicuro, che'l teſtimonio ſolo di uoi, che per altezza d'ingegno, e per ſplendore, e fama di nobilisſime uirtù ſete grandemente chiaro, & illuſtre; porterà tanta grandezza, e tanta auttorità à queſti miei libri che meritamente ſi ſono già fatti uoſtri, ch'io ſolamente per queſto potrò ſperare di uiuer lungamente, & con perpetua lode famoſo, & honorato nella memoria di coloro, che dopo noi uerranno: e con queſta ſperanza, pregandoui felice, e lieta uita; faccio fine.
MERITI amplisimi della uoſtra infinita corteſia (molto Magnifico Signor mio) ſono per li molti Singolarisſimi beneficij, che con perpetua liberalità già tanti, e tanti anni m'hauete fatto continuamente; in tal modo creſciuti, & di numero, & di grandezza: che s'io non cercasſi di rendermiui grato, almeno co'l dimoſtrarmene ſempre ricordeuole; ſon certisſimo, che porterei pericolo di eſſer notato, e tenuto da tutti per diſcorteſe, e per ingrato. E perche fin dalla mia giouanezza mi ſon grandemente dilettato delle coſe di Architettura, onde non ſolamente ho riuolto con faticoſo ſtudio di molt'anni i libri di coloro, che con abbondante felicità d'ingegno hanno arricchito d'eccellentisſimi precetti queſta ſcientia nobilisſima: ma mi ſon traſferito ancora ſpeſſe uolte in Roma, & in altri luoghi d'Italia, e fuori; doue con gli occhi proprij ho ueduto, & con le proprie mani miſurato i fragmenti di molti edificij antichi: iquali ſendo reſtati in piedi fino à noſtri tempi con marauiglioſo ſpettacolo di Barbara crudeltà; rendono anco nelle grandisſime ruine loro chiaro, & illuſtre teſtimonio della uirtù, & della grandezza Romana: in modo che ritrouandomi io grandemente eſercitato, & infiammato ne gli ottimi ſtudij di queſta qualità di Virtù, & hauendo con gran ſperanza meſſo in lei tutti i miei penſieri; mi poſi anco all'impreſa di ſcriuer gli auertimenti neceſſarij, che ſi deuono oſſeruare da tutti i belli ingegni, che ſono deſideroſi di edificar bene, & leggiadramente; & oltra di ciò di moſtrar in diſegno molte di quelle fabriche, che da me ſono ſtate in diuerſi luoghi ordinate; & tutti quelli antichi edificij, c'ho fin'hora ueduti: Però (non già per pagar alcuno degli oblighi infiniti, c'ho contratto con la uoſtra gentilezza, per laquale uoi ſete ſopra ogn'altro amato celebrato, & reputato degno d'ogni altisſimo grado d'honore; ma per dimoſtrarui ſolamente con honorato teſtimonio delle fatiche mie alcun ſegno del mio animo grato, & ricordeuole della grandezza del uoſtro ualore) ui faccio hora un dono di queſti due miei primi libri, oue io tratto delle caſe priuate; ne' quali confeſſo hauer hauuto i Cieli tanto fauoreuoli, che hauendoli io in molte grandi mie occupationi, che quaſi del continuo mi tengono il corpo, e l'animo oppreſſo, & dopo alcune mie non picciole infirmità, finalmente ridotti à quella perfettione, che per me s'è potuta; & hauendo approuato quel tanto, che in lor ſi contiene con lunga eſperienza, ardiſco di dire, d'hauer forſe dato tanto di lume alle coſe di Architettura in queſta parte, che coloro, che dopo me uerranno; potranno con l'eſempio mio, eſercitando l'acutezza de i lor chiari ingegni; ridurre con molta facilità la magnificenza de gli edificij loro alla uera bellezza, e leggiadria de gli antichi. Pregoui dunque Illuſtre mio Signore, che uoi, facendo un'atto degno della uoſtra virtù; uogliate in premio dell'affettion, ch'io ui porto, degnarui di riceuere in dono, & con allegro uolto fauorire queſta prima parte dell'opera mia, che fu già con nobil penſiero incominciata ſotto i felicisſimi auſpicij uoſtri; laquale, come primitie del mio ingegno, ui dedico; & di eſſer contento, che hora, che con tanto fauor della uoſtra liberalità ella ſi ritroua finita; poſſa anco andare con lieto augurio nella luce del Mondo, da ogni parte illuſtrata dal chiarisſimo lume del nome uoſtro; poi che io ſon ſicuro, che'l teſtimonio ſolo di uoi, che per altezza d'ingegno, e per ſplendore, e fama di nobilisſime uirtù ſete grandemente chiaro, & illuſtre; porterà tanta grandezza, e tanta auttorità à queſti miei libri che meritamente ſi ſono già fatti uoſtri, ch'io ſolamente per queſto potrò ſperare di uiuer lungamente, & con perpetua lode famoſo, & honorato nella memoria di coloro, che dopo noi uerranno: e con queſta ſperanza, pregandoui felice, e lieta uita; faccio fine.
In Venetia il Primo di Nouembre. Del M.D.LXX.
Di V.S.
Deuotiſs. Seruitore.
Andrea Palladio.
IL PRIMO LIBRO
DELL'ARCHITETTVRA
DI ANDREA PALLADIO
Proemio à i Lettori
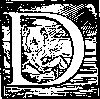 A NATVRALE inclinatione guidato mi diedi nei miei primi anni allo ſtudio dell'Architettura: e perche ſempre fui di opinione che gli Antichi Romani come in molt'altre coſe, coſi nel fabricar bene habbiano di gran lunga auanzato tutti quelli, che dopo loro ſono ſtati; mi propoſi per maeſtro, e guida Vitruuio: il quale è ſolo antico ſcrittore di queſt'arte; & mi miſi alla inueſtigatione delle reliquie de gli Antichi edificij, lequali mal grado del tempo, & della crudeltà de' Barbari ne ſono rimaſe: & ritrouandole di molto maggiore oſſeruatione degne, ch'io nô mi haueua prima penſato; cominciai à miſurare minutiſsimamête con ſomma diligenza ciaſcuna parte loro: delle quali tanto diuenni ſollecito inueſtigatore, nô vi ſapendo conoſcer coſa, che cô ragione, & con bella proportione non fuſſe fatta, che poi non vna, ma più e più volte mi ſon traſferito in diuerſe parti d'Italia, & fuori per potere intieramente da quelle, quale fuſſe il tutto, comprendere, & in diſegno ridurlo. La onde veggendo, quanto queſto commune vſo di fabricare, ſia lontano dalle oſſeruationi da me fatte ne i detti edificij, & lette in Vitruuio, & in Leon Battiſta Alberti, & in altri eccellenti ſcrittori che dopo Vitruuio ſono ſtati, & da quelle ancho, che di nuouo da me ſono ſtate praticate con molta ſodiſfattione, & laude di quelli, che ſi ſono ſeruiti dell'opera mia; mi è parſo coſa degna di huomo; il quale non ſolo à ſe ſteſſo deue eſſer nato, ma ad vtilità ancho de gli altri; il dare in luce i diſegni di quegli edificij, che in tanto tempo, & con tanti miei pericoli ho raccolti, & ponere breuemente ciò che in eſsi m'è parſo più degno di conſideratione; & oltre à ciò quelle regole, che nel fabricare ho oſſeruate, & oſſeruo: à fine che coloro, i quali leggeranno queſti miei libri poſsino ſeruirſi di quel tanto di buono che vi ſarà, & in quelle coſe ſupplire, nelle quali (come che molte forſe ve ne ſaranno) io hauerò mancato: onde coſi à poco à poco s'impari à laſciar da parte gli ſtrani abuſi, le barbare inuentioni, & le ſuperflue ſpeſe, &, (quello che più importa) à ſchifare le varie, e continoue rouine, che in molte fabriche ſi ſono vedute. Et à queſta impreſa tanto più volentieri mi ſon meſſo, quâto ch'io veggo à queſti tempi eſſere aſſaiſsimi di queſta profeſsione ſtudioſi: di molti de' quali ne' ſuoi libri fa degna, & honorata memoria Meſſer Giorgio Vaſari Aretino Pittore, & Architetto raro, onde ſpero che'l modo di fabricare con vniuerſale vtilità ſi habbia à ridurre, e toſto à quel termine, che in tutte le arti è ſommamente deſiderato; & al quale in queſta parte d'Italia par che molto auicinato ſi ſia: concioſia che non ſolo in Venetia, oue tutte le buone arti fioriſcono, & che ſola n'è come eſempio rimaſa della grandezza, & magnificenza de' Romani; ſi comincia à veder fabriche c'hâno del buono, dapoi che Meſſer Giacomo Sanſouino Scultore, & Architetto di nome celebre, cominciò primo à far conoſcere la bella maniera, come ſi vede (per laſciare à dietro molte altre ſue belle opere) nella Procuratia noua, la quale è il più ricco, & ornato edificio, che forſe ſia ſtato fatto da gli Antichi in qua: Ma ancho in molti altri luoghi di minor nome, & maſsimamente in Vicenza Città non molto grande di circuito, ma piena di nobiliſsimi intelletti, & di ricchezze aſſai abbondante: & oue prima ho hauuto occaſione di praticare quello, che hora à commune vtilità mando in luce, ſi ueggono aſſaiſsime belle fabriche, & molti gentil'huomini vi ſono ſtati ſtudioſiſsimi di queſt'arte, i quali e per nobiltà, e per eccellente dottrina non ſono indegni di eſſer annouerati tra i più illuſtri; come il Signor Giouan Giorgio Triſsino ſplendore de' tempi noſtri; & i Signori Conti Marc'Antonio, & Adriano fratelli de' Thieni; & il Signor Antenore Pagello Caualier; e oltre à queſti, i quali paſſati à miglior vita nelle belle, & ornate fabriche loro hanno laſciato di ſe un'eterna memoria; ui è hora il Signor Fabio Monza intelligente di aſſaiſsime coſe; il Signor Elio de' Belli figliuolo che fu del Signor Valerio, celebre per l'artificio de' Camei, & dello ſcolpire in Criſtallo; il Signor Antonio Franceſco Oliuiera, il quale oltra la cognitione di molte ſcienze è Architetto, & Poeta eccellente, come ha dimoſtrato nella ſua Alemana, poema in uerſo Heroico, & in una ſua fabrica a' Boſchi di Nanto, luogo del Vicentino: & finalmente (per laſciare molti altri, i quali con ragione ſi potrebbono in queſto numero porre) il Signor Valerio Barbarano, diligentiſsimo oſſeruatore di tutto quello, che à queſta profeſsione s'appartiene. Ma per ritornare al propoſito noſtro; douendo io dare in luce quelle fatiche, che dalla mia giouanezza infino à qui; ho fatte nell'inueſtigare, & nel miſurar cô tutta quella diligêza, c'ho potuto maggiore, quel tanto de gli antichi edificij, che è peruenuto à notitia mia, e cô queſta occaſione ſotto breuità trattare dell'Architettura più ordinatamente, & diſtintamente, che mi fuſſe poſsibile; ho penſato eſſer molto côueneuole cominciare dalle caſe de' Particolari: ſi perche ſi deue credere, che quelle à i publici edificij le ragioni ſomminiſtraſſero, eſſendo molto veriſimile, che innanzi, l'huomo da per ſe habitaſſe, & dopo vedêdo hauer meſtieri dell'aiuto de gli altri huomini, à côſeguir quelle coſe, che lo poſſono render felice (ſe felicità alcuna ſi ritroua qua giù) la compagnia de gli altri huomini naturalmête deſideraſſe, & amaſſe; onde di molte caſe ſi faceſſero li Borghi, e di molti Borghi poi le Città, & in quelle i luoghi, & gli edificij publichi: ſi ancho, perche tra tutte le parti dell'Architettura; niuna è più neceſſaria à gli huomini, nè che più ſpeſſo ſia praticata di queſta. Io dunque tratterò prima delle caſe priuate, & verrò poi a' publici edificij: e breuemête tratterò delle ſtrade, de i ponti, delle piazze, delle prigioni, delle Baſiliche, cioè luoghi del giudicio, de i Xiſti, e delle Paleſtre, ch'erano luoghi, oue gli huomini ſi eſercitauano; de i Tempij, de i Theatri, & de gli Anfitheatri, de gli Archi, delle Terme, de gli Acquedotti, e finalmente del modo di fortificar le Città, & de i Porti. Et in tutti queſti libri io fuggirò la lunghezza delle parole, & ſemplicemente darò quelle auertenze, che mi parranno più neceſſarie; & mi ſeruirò di quei nomi, che gli artefici hoggidì communemente vſano. E perche di me ſteſſo non poſſo prometter altro, che vna lunga fatica, e gran diligenza, & amore, ch'io ho poſto per intendere, & praticare quanto prometto; s'egli ſarà paciuto à Dio, ch'io nô m'habbia affaticato in darno; ne ringratierò la bontà ſua con tutto il cuore; reſtando appreſſo molto obligato à quelli, che dalle loro belle inuentioni, & dalle eſperienze fatte, ne hanno laſciato i precetti di tal'arte; percioche hanno aperta più facile, & eſpedita ſtrada alla inueſtigatione di coſe nuoue, e di molte (mercè loro) habbiamo cognitione che ne farebbono perauentura naſcoſte. Sarà queſta prima parte in due libri diuiſa: nel primo ſi tratterà della preparatione della materia, e preparata, come, & in che forma ſi debba mettere in opera dalle fondamenta fino al coperto: oue faranno quei precetti, che vniuerſali ſono, & ſi deuono oſſeruare in tutti gli edifici coſi publici, come priuati. Nel ſecondo tratterò della qualità delle fabriche, che à diuerſi gradi d'huomini ſi conuengono, e prima di quelle della Città, e poi de i ſiti opportuni, & commodi per quelle di Villa, e come deono eſſere compartite. Et perche in queſta parte noi habbiamo pochiſsimi eſempi antichi, de' quali ce ne poſsiamo ſeruire; io porrò le piante, & gli impiedi di molte fabriche da me per diuerſi Gentil'huomini ordinate: & i diſegni delle caſe de gli Antichi, & di quelle parti, che in loro più notabili ſono, nel modo, che ci inſegna Vitruuio, che coſi eſsi faceuano.
A NATVRALE inclinatione guidato mi diedi nei miei primi anni allo ſtudio dell'Architettura: e perche ſempre fui di opinione che gli Antichi Romani come in molt'altre coſe, coſi nel fabricar bene habbiano di gran lunga auanzato tutti quelli, che dopo loro ſono ſtati; mi propoſi per maeſtro, e guida Vitruuio: il quale è ſolo antico ſcrittore di queſt'arte; & mi miſi alla inueſtigatione delle reliquie de gli Antichi edificij, lequali mal grado del tempo, & della crudeltà de' Barbari ne ſono rimaſe: & ritrouandole di molto maggiore oſſeruatione degne, ch'io nô mi haueua prima penſato; cominciai à miſurare minutiſsimamête con ſomma diligenza ciaſcuna parte loro: delle quali tanto diuenni ſollecito inueſtigatore, nô vi ſapendo conoſcer coſa, che cô ragione, & con bella proportione non fuſſe fatta, che poi non vna, ma più e più volte mi ſon traſferito in diuerſe parti d'Italia, & fuori per potere intieramente da quelle, quale fuſſe il tutto, comprendere, & in diſegno ridurlo. La onde veggendo, quanto queſto commune vſo di fabricare, ſia lontano dalle oſſeruationi da me fatte ne i detti edificij, & lette in Vitruuio, & in Leon Battiſta Alberti, & in altri eccellenti ſcrittori che dopo Vitruuio ſono ſtati, & da quelle ancho, che di nuouo da me ſono ſtate praticate con molta ſodiſfattione, & laude di quelli, che ſi ſono ſeruiti dell'opera mia; mi è parſo coſa degna di huomo; il quale non ſolo à ſe ſteſſo deue eſſer nato, ma ad vtilità ancho de gli altri; il dare in luce i diſegni di quegli edificij, che in tanto tempo, & con tanti miei pericoli ho raccolti, & ponere breuemente ciò che in eſsi m'è parſo più degno di conſideratione; & oltre à ciò quelle regole, che nel fabricare ho oſſeruate, & oſſeruo: à fine che coloro, i quali leggeranno queſti miei libri poſsino ſeruirſi di quel tanto di buono che vi ſarà, & in quelle coſe ſupplire, nelle quali (come che molte forſe ve ne ſaranno) io hauerò mancato: onde coſi à poco à poco s'impari à laſciar da parte gli ſtrani abuſi, le barbare inuentioni, & le ſuperflue ſpeſe, &, (quello che più importa) à ſchifare le varie, e continoue rouine, che in molte fabriche ſi ſono vedute. Et à queſta impreſa tanto più volentieri mi ſon meſſo, quâto ch'io veggo à queſti tempi eſſere aſſaiſsimi di queſta profeſsione ſtudioſi: di molti de' quali ne' ſuoi libri fa degna, & honorata memoria Meſſer Giorgio Vaſari Aretino Pittore, & Architetto raro, onde ſpero che'l modo di fabricare con vniuerſale vtilità ſi habbia à ridurre, e toſto à quel termine, che in tutte le arti è ſommamente deſiderato; & al quale in queſta parte d'Italia par che molto auicinato ſi ſia: concioſia che non ſolo in Venetia, oue tutte le buone arti fioriſcono, & che ſola n'è come eſempio rimaſa della grandezza, & magnificenza de' Romani; ſi comincia à veder fabriche c'hâno del buono, dapoi che Meſſer Giacomo Sanſouino Scultore, & Architetto di nome celebre, cominciò primo à far conoſcere la bella maniera, come ſi vede (per laſciare à dietro molte altre ſue belle opere) nella Procuratia noua, la quale è il più ricco, & ornato edificio, che forſe ſia ſtato fatto da gli Antichi in qua: Ma ancho in molti altri luoghi di minor nome, & maſsimamente in Vicenza Città non molto grande di circuito, ma piena di nobiliſsimi intelletti, & di ricchezze aſſai abbondante: & oue prima ho hauuto occaſione di praticare quello, che hora à commune vtilità mando in luce, ſi ueggono aſſaiſsime belle fabriche, & molti gentil'huomini vi ſono ſtati ſtudioſiſsimi di queſt'arte, i quali e per nobiltà, e per eccellente dottrina non ſono indegni di eſſer annouerati tra i più illuſtri; come il Signor Giouan Giorgio Triſsino ſplendore de' tempi noſtri; & i Signori Conti Marc'Antonio, & Adriano fratelli de' Thieni; & il Signor Antenore Pagello Caualier; e oltre à queſti, i quali paſſati à miglior vita nelle belle, & ornate fabriche loro hanno laſciato di ſe un'eterna memoria; ui è hora il Signor Fabio Monza intelligente di aſſaiſsime coſe; il Signor Elio de' Belli figliuolo che fu del Signor Valerio, celebre per l'artificio de' Camei, & dello ſcolpire in Criſtallo; il Signor Antonio Franceſco Oliuiera, il quale oltra la cognitione di molte ſcienze è Architetto, & Poeta eccellente, come ha dimoſtrato nella ſua Alemana, poema in uerſo Heroico, & in una ſua fabrica a' Boſchi di Nanto, luogo del Vicentino: & finalmente (per laſciare molti altri, i quali con ragione ſi potrebbono in queſto numero porre) il Signor Valerio Barbarano, diligentiſsimo oſſeruatore di tutto quello, che à queſta profeſsione s'appartiene. Ma per ritornare al propoſito noſtro; douendo io dare in luce quelle fatiche, che dalla mia giouanezza infino à qui; ho fatte nell'inueſtigare, & nel miſurar cô tutta quella diligêza, c'ho potuto maggiore, quel tanto de gli antichi edificij, che è peruenuto à notitia mia, e cô queſta occaſione ſotto breuità trattare dell'Architettura più ordinatamente, & diſtintamente, che mi fuſſe poſsibile; ho penſato eſſer molto côueneuole cominciare dalle caſe de' Particolari: ſi perche ſi deue credere, che quelle à i publici edificij le ragioni ſomminiſtraſſero, eſſendo molto veriſimile, che innanzi, l'huomo da per ſe habitaſſe, & dopo vedêdo hauer meſtieri dell'aiuto de gli altri huomini, à côſeguir quelle coſe, che lo poſſono render felice (ſe felicità alcuna ſi ritroua qua giù) la compagnia de gli altri huomini naturalmête deſideraſſe, & amaſſe; onde di molte caſe ſi faceſſero li Borghi, e di molti Borghi poi le Città, & in quelle i luoghi, & gli edificij publichi: ſi ancho, perche tra tutte le parti dell'Architettura; niuna è più neceſſaria à gli huomini, nè che più ſpeſſo ſia praticata di queſta. Io dunque tratterò prima delle caſe priuate, & verrò poi a' publici edificij: e breuemête tratterò delle ſtrade, de i ponti, delle piazze, delle prigioni, delle Baſiliche, cioè luoghi del giudicio, de i Xiſti, e delle Paleſtre, ch'erano luoghi, oue gli huomini ſi eſercitauano; de i Tempij, de i Theatri, & de gli Anfitheatri, de gli Archi, delle Terme, de gli Acquedotti, e finalmente del modo di fortificar le Città, & de i Porti. Et in tutti queſti libri io fuggirò la lunghezza delle parole, & ſemplicemente darò quelle auertenze, che mi parranno più neceſſarie; & mi ſeruirò di quei nomi, che gli artefici hoggidì communemente vſano. E perche di me ſteſſo non poſſo prometter altro, che vna lunga fatica, e gran diligenza, & amore, ch'io ho poſto per intendere, & praticare quanto prometto; s'egli ſarà paciuto à Dio, ch'io nô m'habbia affaticato in darno; ne ringratierò la bontà ſua con tutto il cuore; reſtando appreſſo molto obligato à quelli, che dalle loro belle inuentioni, & dalle eſperienze fatte, ne hanno laſciato i precetti di tal'arte; percioche hanno aperta più facile, & eſpedita ſtrada alla inueſtigatione di coſe nuoue, e di molte (mercè loro) habbiamo cognitione che ne farebbono perauentura naſcoſte. Sarà queſta prima parte in due libri diuiſa: nel primo ſi tratterà della preparatione della materia, e preparata, come, & in che forma ſi debba mettere in opera dalle fondamenta fino al coperto: oue faranno quei precetti, che vniuerſali ſono, & ſi deuono oſſeruare in tutti gli edifici coſi publici, come priuati. Nel ſecondo tratterò della qualità delle fabriche, che à diuerſi gradi d'huomini ſi conuengono, e prima di quelle della Città, e poi de i ſiti opportuni, & commodi per quelle di Villa, e come deono eſſere compartite. Et perche in queſta parte noi habbiamo pochiſsimi eſempi antichi, de' quali ce ne poſsiamo ſeruire; io porrò le piante, & gli impiedi di molte fabriche da me per diuerſi Gentil'huomini ordinate: & i diſegni delle caſe de gli Antichi, & di quelle parti, che in loro più notabili ſono, nel modo, che ci inſegna Vitruuio, che coſi eſsi faceuano.
QVALI COSE DEONO CONSIDERARSI, E PREPARARSI
auanti che al fabricar ſi peruenga. Cap. I
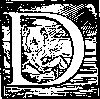 EVESI auanti che à fabricar ſi cominci, diligentemente côſiderare ciaſcuna parte della pianta, & impiedi della fabrica che ſi ha da fare. Tre coſe in ciaſcuna fabrica (come dice Vitruuio) deono conſiderarſi, ſenza lequali niuno edificio meriterà eſſer lodato; & queſte ſono, l'vtile, ò commodità, la perpetuità, & la bellezza: percioche non ſi potrebbe chiamare perfetta quell'opera, che vtile fuſſe, ma per poco tempo; ouero che per molto non fuſſe cômoda; ouero c’hauendo amendue queſte; niuna gratia poi in ſe conteneſſe. La commodità ſi haurà, quando à ciaſcun membro ſarà dato luogo atto, ſito accommodato, non minore che la dignità ſi ricchiegga, ne maggiore che l'vſo ſi ricerchi: & ſarà poſto in luogo proprio, cioè quando le Loggie, le Sale, le Stanze, le Cantine, e i Granari ſaranno poſti a' luoghi loro conueneuoli. Alla perpetuità ſi haurà riſguardo, quando tutti i muri ſaranno diritti à piombo, più groſsi nella parte di ſotto, che in quella di ſopra, & haueranno buone, & ſofficienti le fondamenta: & oltre à ciò, le colonne di ſopra ſaranno al dritto di quelle di ſotto, & tutti i fori, come vſci e feneſtre ſaranno vno ſopra l'altro: onde il pieno venga ſopra il pieno, & il voto ſopra il voto. La bellezza riſulterà dalla bella forma, e dalla corriſpondenza del tutto alle parti, delle parti fra loro, e di quelle al tutto: concioſiache gli edificij habbiano da parere vno intiero, e ben finito corpo: nel quale l'vn membro all'altro conuenga, & tutte le membra ſiano neceſſarie à quello, che ſi vuol fare. Côſiderate queſte coſe, nel diſegno, e nel Modello; ſi deue fare diligentemente il conto di tutta la ſpeſa, che vi può andare: e fare à tempo prouiſione del danaro, e apparecchiare la materia, che parerà far di meſtieri; accioche edificâdo, non manchi alcuna coſa, che impediſca il compimento dell'opera, eſſendo che non picciola lode ſia dell'edificatore, e non mediocre vtilità à tutta la fabrica; ſe con la debita preſtezza vien fornita, & che tutti i muri ad egual ſegno tirati; egualmête calino: onde non facciano quelle feſſure, che ſi ſogliono vedere nelle fabriche in diuerſi tempi, & inegualmente condotte al fine. E però eletti i più periti artefici, che ſi poſſano hauere, accioche ottimamente l'opera ſia dirizzata, ſecondo il loro conſiglio; ſi prouederà di legnami, di pietre, d'arena, di calce, e di metalli: circa lequali prouiſioni ſi haueranno alcune auertêze, come che per fare le trauamenta de' ſolari delle Sale, e delle ſtanze, di tante traui ſi proueda, che ponendole tutte in opera; reſti fra l'vna, e l'altra lo ſpatio di vna groſſezza, e meza di traue: medeſimamente circa le pietre; ſi auertirà, che per fare le erte delle porte, e delle feneſtre; non ſi ricercano pietre più groſſe della quinta parte della larghezza della luce, nè meno della ſeſta. E ſe nella fabrica anderanno adornamenti di colonne, ò di pilaſtri; ſi potranno far le baſe, i capitelli, e gli architraui di pietra, e l'altre parti di pietra cotta. Circa i muri ancora ſi hauerà côſideratione, che ſi deono diminuire ſecondo che ſi inalzano: lequali auertenze gioueranno à fare il conto giuſto, e ſcemeranno gran parte della ſpeſa. E perche di tutte queſte parti ſi dirà minutamente a' luoghi loro; baſterà per hora hauer dato queſta vniuerſale cognitione, e fatto come un'abbozzamento di tutta la fabrica. Ma perche oltra la quantità, ſi deue ancho hauer conſideratione alla qualità, e bontà della materia; ad elegger la migliore; ci giouarà molto la eſperienza pigliata dalle fabriche fatte da gli altri: perche da quelle auiſati; potremo facilmente determinare ciò che a' biſogni noſtri ſia acconcio, & eſpediente. E benche Vitruuio, Leon Battiſta Alberti, & altri eccellenti ſcrittori habbiano dato quegli auuertimenti, che ſi debbono hauere nell'elegger eſſa materia; io nondimeno acciò che niente in queſti miei libri paia mancare, ne dirò alcuni, reſtringendomi à i più neceſſarij.
EVESI auanti che à fabricar ſi cominci, diligentemente côſiderare ciaſcuna parte della pianta, & impiedi della fabrica che ſi ha da fare. Tre coſe in ciaſcuna fabrica (come dice Vitruuio) deono conſiderarſi, ſenza lequali niuno edificio meriterà eſſer lodato; & queſte ſono, l'vtile, ò commodità, la perpetuità, & la bellezza: percioche non ſi potrebbe chiamare perfetta quell'opera, che vtile fuſſe, ma per poco tempo; ouero che per molto non fuſſe cômoda; ouero c’hauendo amendue queſte; niuna gratia poi in ſe conteneſſe. La commodità ſi haurà, quando à ciaſcun membro ſarà dato luogo atto, ſito accommodato, non minore che la dignità ſi ricchiegga, ne maggiore che l'vſo ſi ricerchi: & ſarà poſto in luogo proprio, cioè quando le Loggie, le Sale, le Stanze, le Cantine, e i Granari ſaranno poſti a' luoghi loro conueneuoli. Alla perpetuità ſi haurà riſguardo, quando tutti i muri ſaranno diritti à piombo, più groſsi nella parte di ſotto, che in quella di ſopra, & haueranno buone, & ſofficienti le fondamenta: & oltre à ciò, le colonne di ſopra ſaranno al dritto di quelle di ſotto, & tutti i fori, come vſci e feneſtre ſaranno vno ſopra l'altro: onde il pieno venga ſopra il pieno, & il voto ſopra il voto. La bellezza riſulterà dalla bella forma, e dalla corriſpondenza del tutto alle parti, delle parti fra loro, e di quelle al tutto: concioſiache gli edificij habbiano da parere vno intiero, e ben finito corpo: nel quale l'vn membro all'altro conuenga, & tutte le membra ſiano neceſſarie à quello, che ſi vuol fare. Côſiderate queſte coſe, nel diſegno, e nel Modello; ſi deue fare diligentemente il conto di tutta la ſpeſa, che vi può andare: e fare à tempo prouiſione del danaro, e apparecchiare la materia, che parerà far di meſtieri; accioche edificâdo, non manchi alcuna coſa, che impediſca il compimento dell'opera, eſſendo che non picciola lode ſia dell'edificatore, e non mediocre vtilità à tutta la fabrica; ſe con la debita preſtezza vien fornita, & che tutti i muri ad egual ſegno tirati; egualmête calino: onde non facciano quelle feſſure, che ſi ſogliono vedere nelle fabriche in diuerſi tempi, & inegualmente condotte al fine. E però eletti i più periti artefici, che ſi poſſano hauere, accioche ottimamente l'opera ſia dirizzata, ſecondo il loro conſiglio; ſi prouederà di legnami, di pietre, d'arena, di calce, e di metalli: circa lequali prouiſioni ſi haueranno alcune auertêze, come che per fare le trauamenta de' ſolari delle Sale, e delle ſtanze, di tante traui ſi proueda, che ponendole tutte in opera; reſti fra l'vna, e l'altra lo ſpatio di vna groſſezza, e meza di traue: medeſimamente circa le pietre; ſi auertirà, che per fare le erte delle porte, e delle feneſtre; non ſi ricercano pietre più groſſe della quinta parte della larghezza della luce, nè meno della ſeſta. E ſe nella fabrica anderanno adornamenti di colonne, ò di pilaſtri; ſi potranno far le baſe, i capitelli, e gli architraui di pietra, e l'altre parti di pietra cotta. Circa i muri ancora ſi hauerà côſideratione, che ſi deono diminuire ſecondo che ſi inalzano: lequali auertenze gioueranno à fare il conto giuſto, e ſcemeranno gran parte della ſpeſa. E perche di tutte queſte parti ſi dirà minutamente a' luoghi loro; baſterà per hora hauer dato queſta vniuerſale cognitione, e fatto come un'abbozzamento di tutta la fabrica. Ma perche oltra la quantità, ſi deue ancho hauer conſideratione alla qualità, e bontà della materia; ad elegger la migliore; ci giouarà molto la eſperienza pigliata dalle fabriche fatte da gli altri: perche da quelle auiſati; potremo facilmente determinare ciò che a' biſogni noſtri ſia acconcio, & eſpediente. E benche Vitruuio, Leon Battiſta Alberti, & altri eccellenti ſcrittori habbiano dato quegli auuertimenti, che ſi debbono hauere nell'elegger eſſa materia; io nondimeno acciò che niente in queſti miei libri paia mancare, ne dirò alcuni, reſtringendomi à i più neceſſarij.
DE I LEGNAMI. Cap. II
 LEGNAMI (come ha Vitruuio al cap. ix. del ij. lib.) ſi deono tagliare l'Autunno, e per tutto il Verno, percioche allhora gli alberi ricuperano dalle radici quel vigore, e ſodezza, che nella Primauera, e nella Eſtate per le frondi, e per li frutti era ſparſo: e ſi taglieranno mancando la Luna; perche quell'humore, che à corrompere i legni è attiſſimo; à quel tempo è conſumato: onde non vengono poi da tignole, ò da tarli offeſi. Si deono tagliare ſolamente ſino al mezzo della midolla, e coſi laſciarli fin che ſi ſecchino: percioche ſtillando; vſcirà fuori quell'humore, che ſarà atto alla putrefattione. Tagliati; ſi riporranno in luogo, oue non vengano caldiſsimi Soli, nè impetuoſi venti, nè pioggie: e quelli maſsimamente deono eſſere tenuti al coperto, che da ſe ſteſsi naſcono: & accioche non ſi fendano, & egualmête ſi ſecchino; ſi vngeranno di ſterco di bue. Non ſi deono tirare per la rugiada, ma dopo il mezzodì: nè ſi deono lauorare, eſſendo di rugiada bagnati, ò molto ſecchi; percioche quelli facilmente ſi corrompono, e queſti fanno bruttiſsimo lauoro: Nè auanti tre anni ſaranno ben ſecchi per vſo de' palchi, e delle porte, e delle feneſtre. Biſogna che i padroni, che uogliono fabricare; s'informino bene da i periti, della natura de i legnami, e qual legno à qual coſa è buono, e quale non. Vitruuio al detto luogo ne dà buona inſtruttione, & altri dotti huomini, che ne han ſcritto copioſamête.
LEGNAMI (come ha Vitruuio al cap. ix. del ij. lib.) ſi deono tagliare l'Autunno, e per tutto il Verno, percioche allhora gli alberi ricuperano dalle radici quel vigore, e ſodezza, che nella Primauera, e nella Eſtate per le frondi, e per li frutti era ſparſo: e ſi taglieranno mancando la Luna; perche quell'humore, che à corrompere i legni è attiſſimo; à quel tempo è conſumato: onde non vengono poi da tignole, ò da tarli offeſi. Si deono tagliare ſolamente ſino al mezzo della midolla, e coſi laſciarli fin che ſi ſecchino: percioche ſtillando; vſcirà fuori quell'humore, che ſarà atto alla putrefattione. Tagliati; ſi riporranno in luogo, oue non vengano caldiſsimi Soli, nè impetuoſi venti, nè pioggie: e quelli maſsimamente deono eſſere tenuti al coperto, che da ſe ſteſsi naſcono: & accioche non ſi fendano, & egualmête ſi ſecchino; ſi vngeranno di ſterco di bue. Non ſi deono tirare per la rugiada, ma dopo il mezzodì: nè ſi deono lauorare, eſſendo di rugiada bagnati, ò molto ſecchi; percioche quelli facilmente ſi corrompono, e queſti fanno bruttiſsimo lauoro: Nè auanti tre anni ſaranno ben ſecchi per vſo de' palchi, e delle porte, e delle feneſtre. Biſogna che i padroni, che uogliono fabricare; s'informino bene da i periti, della natura de i legnami, e qual legno à qual coſa è buono, e quale non. Vitruuio al detto luogo ne dà buona inſtruttione, & altri dotti huomini, che ne han ſcritto copioſamête.
DELLE PIETRE. Cap. III.
 ELLE pietre altre habbiamo dalla Natura, altre ſono fatte dall'induſtria de gli huomini: le naturali ſi cauano dalle pietraie, e ſono ò per far la calce, ò per fare i muri: di quelle, che ſi tolgono per far la calce; ſi dirà più ſotto: Quelle delle quali ſi fanno i muri, ò ſono marmi, e pietre dure, che ſi dicono ancho pietre viue; ouero ſono pietre molli, e tenere. I marmi, e le pietre viue ſi lauoreranno ſubito cauate: perche ſarà più facile il lauorarle all'hora, che ſe per alcun tempo fuſſero ſtate all'aere, eſſendo che tutte le pietre, quanto più ſtanno cauate, tanto più diuengono dure: e ſi potranno metter ſubito in opera. Ma le pietre molli, e tenere, maſsimamente ſe la natura, e ſoficienza loro ci ſarà incognita, come quando ſi cauaſſero in luogo, oue per adietro non ne foſſero ſtate cauate; ſi deono cauare la Eſtate, e tenere allo ſcoperto, nè ſi porranno anzi due anni in opera: ſi cauano la Eſtate, accioche non eſſendo elle auezze a' venti, alle pioggie, & al ghiaccio; à poco à poco ſi induriſcano, & diuengano atte à reſiſtere à ſimili ingiurie de' tempi. Et tanto tempo ſi laſciano, accioche ſcelte quelle, che ſaranno ſtate offeſe; ſiano poſte nelle fondamenta, e l'altre non guaſte, come approuate; ſi pongano ſopra la terra nelle fabriche: perche lungamente ſi manterranno. Le pietre, che ſi fanno da gli huomini, volgarmête per la loro forma ſi chiamano quadrelli: queſte deono farſi di terra cretoſa, bianchiccia, e domabile: ſi laſcierà del tutto la terra ghiaroſa, e ſabbioniccia. Si cauerà la terra nell'Autunno, e ſi macererà nel Verno, e ſi formeranno poi i quadrelli commodamente la Primauera. Ma ſe la neceſſità ſtrigneſſe à formagli il Verno, ò la Eſtate; ſi copriranno il Verno di ſecca arena, e la Eſtate di paglia. Formati deonſi ſeccare per molto tempo, & è meglio ſeccargli all'ombra, accioche non ſolamente nella ſuperficie, ma ancho nelle parti di mezo, ſiano egualmente ſecchi: il che non ſi fa in meno di due anni. Si fanno e maggiori, e minori ſecondo la qualità de gli Edificij da farſi, e ſecondo che di loro ci vogliamo ſeruire: onde gli Antichi fecero i mattoni de i publici, e grandi edificij molto maggiori de i piccioli, e priuati, Quelli che alquanto groſsi ſi fanno; ſi deono forare in più luoghi, acciò che meglio ſi ſecchino, e cuocano.
ELLE pietre altre habbiamo dalla Natura, altre ſono fatte dall'induſtria de gli huomini: le naturali ſi cauano dalle pietraie, e ſono ò per far la calce, ò per fare i muri: di quelle, che ſi tolgono per far la calce; ſi dirà più ſotto: Quelle delle quali ſi fanno i muri, ò ſono marmi, e pietre dure, che ſi dicono ancho pietre viue; ouero ſono pietre molli, e tenere. I marmi, e le pietre viue ſi lauoreranno ſubito cauate: perche ſarà più facile il lauorarle all'hora, che ſe per alcun tempo fuſſero ſtate all'aere, eſſendo che tutte le pietre, quanto più ſtanno cauate, tanto più diuengono dure: e ſi potranno metter ſubito in opera. Ma le pietre molli, e tenere, maſsimamente ſe la natura, e ſoficienza loro ci ſarà incognita, come quando ſi cauaſſero in luogo, oue per adietro non ne foſſero ſtate cauate; ſi deono cauare la Eſtate, e tenere allo ſcoperto, nè ſi porranno anzi due anni in opera: ſi cauano la Eſtate, accioche non eſſendo elle auezze a' venti, alle pioggie, & al ghiaccio; à poco à poco ſi induriſcano, & diuengano atte à reſiſtere à ſimili ingiurie de' tempi. Et tanto tempo ſi laſciano, accioche ſcelte quelle, che ſaranno ſtate offeſe; ſiano poſte nelle fondamenta, e l'altre non guaſte, come approuate; ſi pongano ſopra la terra nelle fabriche: perche lungamente ſi manterranno. Le pietre, che ſi fanno da gli huomini, volgarmête per la loro forma ſi chiamano quadrelli: queſte deono farſi di terra cretoſa, bianchiccia, e domabile: ſi laſcierà del tutto la terra ghiaroſa, e ſabbioniccia. Si cauerà la terra nell'Autunno, e ſi macererà nel Verno, e ſi formeranno poi i quadrelli commodamente la Primauera. Ma ſe la neceſſità ſtrigneſſe à formagli il Verno, ò la Eſtate; ſi copriranno il Verno di ſecca arena, e la Eſtate di paglia. Formati deonſi ſeccare per molto tempo, & è meglio ſeccargli all'ombra, accioche non ſolamente nella ſuperficie, ma ancho nelle parti di mezo, ſiano egualmente ſecchi: il che non ſi fa in meno di due anni. Si fanno e maggiori, e minori ſecondo la qualità de gli Edificij da farſi, e ſecondo che di loro ci vogliamo ſeruire: onde gli Antichi fecero i mattoni de i publici, e grandi edificij molto maggiori de i piccioli, e priuati, Quelli che alquanto groſsi ſi fanno; ſi deono forare in più luoghi, acciò che meglio ſi ſecchino, e cuocano.
DELL'ARENA. Cap. IIII.
 I RITROVA ſabbia, ouero Arena di tre ſorti, cioè di caua, di fiume, e di mare. Quella di caua è di tutte migliore, & è ò nera , o bianca, ò roſſa, ò carboncino, che è vna ſorte di terra arſa dal fuoco rinchiuſo ne' monti, e ſi caua in Toſcana. Si caua ancho in Terra di Lauoro nel territorio di Baia, e di Cuma, vna poluere detta da Vitruuio Pozzolana: la quale nelle acque fa preſtiſsimo preſa, e rende gli edificij fortiſsimi. Per lunga eſperienza ſi è viſto, che la bianca tra le arene di caua è la peggiore, & che fra le arene di fiume la migliore è quella di torrente, che ſi troua ſotto la balza, onde l'acqua ſcende: perche è più purgata. L'arena di mare è di tutte l'altre men buona; e deue negreggiare, & eſſere come uetro lucida: ma quella è migliore, che è più uicina al litto, & è più groſſa. L'Arena di caua perche è graſſa; è più tenace: ma ſi fende facilmente: e però ſi vſa ne i muri, e ne i volti continouati. Quella di fiume è buoniſsima per le intonicature, ò uogliam dire per la ſmaltatura di fuori. Quella di mare, perche toſto ſi ſecca, e preſto ſi bagna, e ſi diſfà per lo ſalſo; è meno atta à ſoſtenere i peſi. Sarà ogni ſabbia nella ſua ſpecie ottima, ſe con mani premuta, e maneggiata ſtriderà: e che poſta ſopra candida veſte non la macchierà, nè vi laſcierà terra. Cattiua ſarà quella, che nell'acqua meſcolata la farà torbida, e fangoſa, e che lungo tempo ſarà ſtata all'Aria, al Sole alla Luna, & alla Pruina: percioche haurà aſſai di terreno, e di marcio humore, atto à produrre arboſcelli, e fichi ſeluatichi, che ſono di grandiſsimo danno alla fabriche.
I RITROVA ſabbia, ouero Arena di tre ſorti, cioè di caua, di fiume, e di mare. Quella di caua è di tutte migliore, & è ò nera , o bianca, ò roſſa, ò carboncino, che è vna ſorte di terra arſa dal fuoco rinchiuſo ne' monti, e ſi caua in Toſcana. Si caua ancho in Terra di Lauoro nel territorio di Baia, e di Cuma, vna poluere detta da Vitruuio Pozzolana: la quale nelle acque fa preſtiſsimo preſa, e rende gli edificij fortiſsimi. Per lunga eſperienza ſi è viſto, che la bianca tra le arene di caua è la peggiore, & che fra le arene di fiume la migliore è quella di torrente, che ſi troua ſotto la balza, onde l'acqua ſcende: perche è più purgata. L'arena di mare è di tutte l'altre men buona; e deue negreggiare, & eſſere come uetro lucida: ma quella è migliore, che è più uicina al litto, & è più groſſa. L'Arena di caua perche è graſſa; è più tenace: ma ſi fende facilmente: e però ſi vſa ne i muri, e ne i volti continouati. Quella di fiume è buoniſsima per le intonicature, ò uogliam dire per la ſmaltatura di fuori. Quella di mare, perche toſto ſi ſecca, e preſto ſi bagna, e ſi diſfà per lo ſalſo; è meno atta à ſoſtenere i peſi. Sarà ogni ſabbia nella ſua ſpecie ottima, ſe con mani premuta, e maneggiata ſtriderà: e che poſta ſopra candida veſte non la macchierà, nè vi laſcierà terra. Cattiua ſarà quella, che nell'acqua meſcolata la farà torbida, e fangoſa, e che lungo tempo ſarà ſtata all'Aria, al Sole alla Luna, & alla Pruina: percioche haurà aſſai di terreno, e di marcio humore, atto à produrre arboſcelli, e fichi ſeluatichi, che ſono di grandiſsimo danno alla fabriche.
DELLA CALCE, E MODO D'IMPASTARLA. Cap. V.
 E PIETRE per far la calce, ò ſi cauano da i monti, ò ſi pigliano da i fiumi. Ogni pietra de' monti è buona, che ſia ſecca, di humori purgata, e frale, e che non habbia in ſe altra materia, che conſumata dal fuoco, laſci la pietra minore: onde ſarà miglior quella, che ſarà fatta di pietra duriſſima, ſoda, e bianca, e che cotta rimarrà il terzo più leggiera della ſua pietra. Sono ancho certe ſorti di pietre ſpugnoſe, la calce delle quali ſarà molto buona all'intonicature de' muri. Si cauano ne i monti di Padoa alcune pietre ſcaglioſe, la calce delle quali è eccellente nelle opere che ſi fanno allo ſcoperto, & nell'acque: percioche preſto fa preſa, e ſi mantiene lungamente. Ogni pietra cauata à far la calce è migliore della raccolta, e di ombroſa, & humida caua più toſto che di ſecca, e di bianca meglio ſi adopra, che di bruna. Le pietre che ſi pigliano da i fiumi, e torrenti, cioè i ciottoli, ò cuocoli; fanno calce boniſsima, che fa molto bianco, e polito lauoro: onde per lo più ſi vſa nelle intonicature de' muri. Ogni pietra ſi de' monti, come de' fiumi ſi cuoce più, e manco preſto ſecondo il fuoco che le uien dato: ma regolarmente cuoceſi in hore ſeſſanta. Cotta ſi deue bagnare, e non infondere in vna volta tutta l'acqua, ma in più fiate, continuatamente però acciò che non ſi abbruci, fin ch'ella ſia bene ſtemperata. Dipoi ſi riponga in luogo humido, e nell'ombra, ſenza meſcolarui coſa alcuna, ſolamente di leggiera ſabbia coprendola: e quanto ſarà più macerata, tanto ſarà più tence, e migliore, eccetto quella, che di pietra ſcaglioſa ſarà fatta, come la Padouana; perche ſubito bagnata; biſogna metterla in opera: altrimenti ſi conſuma, & abbrucia: onde non fa preſa, e diuiene del tutto inutile. Per far la malta ſi deue in queſto modo con la ſabbia meſcolare; che pigliandoſi arena di caua; ſi pongano tre parti di eſſa, & vna di calce: ſe di fiume, ò di mare; due parti di arena, & vna di calce.
E PIETRE per far la calce, ò ſi cauano da i monti, ò ſi pigliano da i fiumi. Ogni pietra de' monti è buona, che ſia ſecca, di humori purgata, e frale, e che non habbia in ſe altra materia, che conſumata dal fuoco, laſci la pietra minore: onde ſarà miglior quella, che ſarà fatta di pietra duriſſima, ſoda, e bianca, e che cotta rimarrà il terzo più leggiera della ſua pietra. Sono ancho certe ſorti di pietre ſpugnoſe, la calce delle quali ſarà molto buona all'intonicature de' muri. Si cauano ne i monti di Padoa alcune pietre ſcaglioſe, la calce delle quali è eccellente nelle opere che ſi fanno allo ſcoperto, & nell'acque: percioche preſto fa preſa, e ſi mantiene lungamente. Ogni pietra cauata à far la calce è migliore della raccolta, e di ombroſa, & humida caua più toſto che di ſecca, e di bianca meglio ſi adopra, che di bruna. Le pietre che ſi pigliano da i fiumi, e torrenti, cioè i ciottoli, ò cuocoli; fanno calce boniſsima, che fa molto bianco, e polito lauoro: onde per lo più ſi vſa nelle intonicature de' muri. Ogni pietra ſi de' monti, come de' fiumi ſi cuoce più, e manco preſto ſecondo il fuoco che le uien dato: ma regolarmente cuoceſi in hore ſeſſanta. Cotta ſi deue bagnare, e non infondere in vna volta tutta l'acqua, ma in più fiate, continuatamente però acciò che non ſi abbruci, fin ch'ella ſia bene ſtemperata. Dipoi ſi riponga in luogo humido, e nell'ombra, ſenza meſcolarui coſa alcuna, ſolamente di leggiera ſabbia coprendola: e quanto ſarà più macerata, tanto ſarà più tence, e migliore, eccetto quella, che di pietra ſcaglioſa ſarà fatta, come la Padouana; perche ſubito bagnata; biſogna metterla in opera: altrimenti ſi conſuma, & abbrucia: onde non fa preſa, e diuiene del tutto inutile. Per far la malta ſi deue in queſto modo con la ſabbia meſcolare; che pigliandoſi arena di caua; ſi pongano tre parti di eſſa, & vna di calce: ſe di fiume, ò di mare; due parti di arena, & vna di calce.
DE I METALLI. Cap. VI.
 METALLI, che nelle fabriche ſi adoperano; ſono il ferro, il piombo, & il rame. Il ferro ſerue per fare i chiodi, i cardini, i catenacci, co' quali ſi chiudono le porte: per fare le porte iſteſſe, le ſerrate, e ſimili lauori. In niun luogo egli ſi ritroua, e caua puro: ma cauato ſi purga co'l fuoco: concioſia che egli ſi liquefaccia in modo, che ſi può fondere: e coſi auanti che ſi raffreddi; ſe gli leuano le feccie: ma dapoi ch'è purgato, e raffreddato; ſi accende bene, e diuenta molle, e ſi laſcia dal martello maneggiare, e ſtendere. Ma non può già facilmente fonderſi, ſe non è di nuouo meſſo in fornaci fatte per queſto effetto: ſe infocato, & acceſo non ſi lauora, e reſtrigne à colpi di martello; ſi corrompe, e conſuma. Sarà ſegno della bontà del ferro, ſe ridotto in maſſa; ſi vedranno le ſue uene continouate, e diritte, & non interrotte: e ſe le teſte della maſſa ſaranno nette, e ſenza feccie: perche le dette uene dimoſtrerâno che'l ferro ſia ſenza groppi, e ſenza ſfogli; e per le teſte ſi conoſcerà, quale egli ſia nel mezo: ma ſe ſarà ridotto in lamine quadre, ò di altra figura, ſe i lati ſaranno diritti; diremo ch'egli ſia vgualmente buono, hauendo potuto ugualmente reſiſtere à i colpi de i martelli.
METALLI, che nelle fabriche ſi adoperano; ſono il ferro, il piombo, & il rame. Il ferro ſerue per fare i chiodi, i cardini, i catenacci, co' quali ſi chiudono le porte: per fare le porte iſteſſe, le ſerrate, e ſimili lauori. In niun luogo egli ſi ritroua, e caua puro: ma cauato ſi purga co'l fuoco: concioſia che egli ſi liquefaccia in modo, che ſi può fondere: e coſi auanti che ſi raffreddi; ſe gli leuano le feccie: ma dapoi ch'è purgato, e raffreddato; ſi accende bene, e diuenta molle, e ſi laſcia dal martello maneggiare, e ſtendere. Ma non può già facilmente fonderſi, ſe non è di nuouo meſſo in fornaci fatte per queſto effetto: ſe infocato, & acceſo non ſi lauora, e reſtrigne à colpi di martello; ſi corrompe, e conſuma. Sarà ſegno della bontà del ferro, ſe ridotto in maſſa; ſi vedranno le ſue uene continouate, e diritte, & non interrotte: e ſe le teſte della maſſa ſaranno nette, e ſenza feccie: perche le dette uene dimoſtrerâno che'l ferro ſia ſenza groppi, e ſenza ſfogli; e per le teſte ſi conoſcerà, quale egli ſia nel mezo: ma ſe ſarà ridotto in lamine quadre, ò di altra figura, ſe i lati ſaranno diritti; diremo ch'egli ſia vgualmente buono, hauendo potuto ugualmente reſiſtere à i colpi de i martelli.
Di piombo ſi cuoprono i Palagi magnifici, i Tempij, le torri, & altri edificij publici: ſi fanno le fiſtule, ò canaletti che diciamo da condurre le acque: e ſi affermano con piombo i cardini, e le ferrate nelle erte delle porte, e delle fineſtre. Si ritroua di tre ſorti, cioè bianco, negro, e di color mezano, tra queſti due; onde da alcuni è detto Cineraccio: Il negro coſi ſi chiama, non perche ſia ueramente negro, ma perche è bianco con alquanto di negrezza: onde à riſpetto del bianco con ragione gli Antichi gli diedero tal nome. Il bianco è più perfetto, e più precioſo del negro: Il cineraccio tiene tra queſti due vn luogo di mezo. Si caua il piombo ò in maſſe grandi, lequali ſi ritrouano da per ſe ſenza altro; ò ſi cauano di lui maſſe picciole, che lucono con certa negrezza: ò ſi trouano le ſue ſottiliſsime ſfoglie attaccate ne i ſaſsi, ne i marmi, e nelle pietre. Ogni ſorte di piombo facilmente ſi fonde: perche con l'ardore del fuoco ſi liquefà prima che ſi accenda: ma poſto in fornaci ardentiſsime non conſerua la ſua ſpecie, e non dura: perche una parte ſi muta in litargirio, un'altra in Molibdena. Di queſte ſorti di piombo, il negro è molle, e per queſto ſi laſcia facilmente maneggiar dal martello, e dilatarſi molto, & è peſante, e grieue: il bianco è più duro, & è leggiero: il cineraccio è molto più duro del bianco, & quanto al peſo tiene il luogo di mezo.
Di Rame ſi cuoprono alcuna volta gli edificij publici, e ne fecero gli Antichi i chiodi, che doroni uolgarmente ſi chiamano: iquali nella pietra di ſotto, & in quella di ſopra fiſsi, vietano che le pietre non uengano ſpinte di ordine, & gli arpeſi, che ſi pongono per tenire vnite, e congiunte inſieme due pietre à paro; & di queſti chiodi, & arpeſi ci ſeruimo, accioche tutto l'edificio, ilquale per neceſsità non ſi può fare ſe non di molti pezzi di pietra, eſſendo quelli in tal modo congiunti, e legati inſieme; venga ad eſſere come di vn pezzo ſolo, e coſi molto più forte, e durabile. Si fanno ancho chiodi & arpeſi di ferro, ma eſsi li fecero per lo più di rame, perche meno dal tempo può eſſere conſumato, eſſendo ch'egli non rugginiſca. Ne fecero ancho le lettere per le inſcrittioni, che ſi pongono nel fregio de gli edificij, e ſi legge che di queſto metallo erano le cento porte celebri di Babilonia; e nell'Iſole di Gade due colonne di Hercole alte otto cubiti. Si tiene per eccellentiſsimo, e per lo migliore quello, che cotto, e cauato per uia del fuoco dalle minerali è di color roſſo tendente al giallo, & è ben fiorito, cioè pieno di buchi: perche queſto è ſegno ch'egli ſia purgato, e libero da ogni feccia. Il rame ſi accende come il ferro, e ſi liquefà, onde ſi può fondere: ma in ardentiſsime fornaci poſto non tolera le forze delle fiamme, ma ſi conſuma à fatto. Egli benche ſia duro ſi laſcia nondimeno maneggiare dal ferro, e dilatarſi ancho in ſottili ſfoglie. Si conſerua nella pece liquida ottimamente, e tutto che non ſi rugginiſca, come il ferro; fa nondimeno ancor egli la ſua ruggine, che chiamiamo uerde rame, maſsimamente ſe tocca coſe acri, e liquide. Di queſto metallo meſcolato con ſtagno, ò piombo, ò ottone che ancor eſſo è rame, ma colorito con la terra cadmia; ſi fa vn miſto detto uolgarmente Bronzo: del quale ſpeſsiſsime uolte gli Architetti ſi ſeruono: percioche ſe ne fanno baſe, colonne, capitelli, ſtatue, & altre coſe ſimili. Si ueggono in Roma in San Giouanni Laterano quattro colonne di Bronzo: delle quali vna ſola ha il capitello: e le fece fare Auguſto del metallo, ch'era negli ſperoni delle naui ch'egli conquiſtò in Egitto contra M. Antonio. Ne ſono ancho reſtate in Roma fin ad hoggi quattro antiche porte, cioè quelle della Ritonda, che fu già il Pantheone: quella di Santo Adriano, che fu il Tempio di Saturno: quella di S. Coſmo, e Damiano, che fu il Tempio di Caſtore, e Polluce, ò pure di Romulo, e Remo: & quella, che ſi vede in Santa Agneſe fuori della porta Viminale, hoggi detta Santa Agneta, ſu la via Numentana. Ma la più bella di tutte queſte è quella di Santa Maria Ritonda: nella quale volſero quegli Antichi imitare con l'arte quella ſpecie di metallo Corinthio, in cui preualſe più la natura gialla dell'oro: percioche noi leggiamo che quando fu deſtrutto, & arſo Corintho, che hora ſi chiama Coranto; ſi liquefecero, & vnirono in vna maſſa l'oro, l'argento, & il rame, e la fortuna temprò, e fe' la miſtura di tre ſpecie di rame, che fù poi detto Corinthio: in vna dellequali preualſe l'argento, onde reſtò bianca, e ſi accoſtò molto col ſuo ſplendore à quello: in vna altra preualſe l'oro, e però reſtò gialla, e di color d'oro: e la terza fu quella, doue fu vguale il temperamento di tutti queſti tre metalli; e queſte ſpecie ſono ſtate poi diuerſamente imitate da gli huomini. Io ho fin qui eſpoſto quanto mi è parſo neceſſario di quelle coſe, che ſi deono conſiderare, & appreſtare, auanti che à fabricar ſi incominci: reſta hora che alcuna coſa diciamo de' fondamenti: da' quali la preparata materia ſi comincia à mettere in opera.
DELLA QVALITÀ DEL TERRENO, OVE S'HANNO DA
poner le fondamenta. Cap. VII.
 E FONDAMENTA propriamente ſi dicono la baſe della fabrica, cioè quella parte, ch'è ſotto terra: laquale ſoſtenta tutto l'edificio, che ſopra terra ſi uede. Però tra tutti gli errori, ne' quali fabricando ſi può incorrere; ſono dannoſiſsimi quelli, che nelle fondamenta ſi commettono: perche apportano ſeco la rouina di tutta l'opera, nè ſi ponno ſenza grandiſsima difficultà emendare: onde l'Architetto deue ponerui ogni ſua diligenza; percioche in alcun luogo ſi hanno fondamenta dalla Natura, e altroue è biſogno vſarui l'arte. Dalla Natura habbiamo le fondamenta, quando ſi ha da fabricare ſopra il ſaſſo, toſo, e ſcaranto: ilquale è vna ſorte di terreno, che tiene in parte della pietra: percioche queſti ſenza biſogno di cauamento, ò d'altro aiuto dell'arte ſono da ſe ſteſsi buoniſsimo fondamento, & attiſsimo à ſoſtenere ogni grande edificio, coſi in terra, come ne i fiumi. Ma ſe la Natura non ſomminiſtrerà le fondamenta; ſarà di meſtieri cercarle con l'arte, & all'hora, ò ſi haurà da fabricare in terren ſodo, ouero in luogo, oue ſia ghiara, ò arena, ò terren moſſo, ò molle, e paludoſo. Se'l terren ſarà ſodo, e fermo; tanto in quello ſi cauerà ſotto, quanto parerà al giudicioſo Architetto, che richieda la qualità della fabrica, e la ſodezza di eſſo terreno. laquale cauatione per lo più farà la ſeſta parte dell'altezza dell'edificio, non uolendoui far cantine, ò altri luoghi ſotterranei. A conoſcer queſta ſodezza, giouerà l'oſſeruanza delle cauationi de' pozzi, delle ciſterne, & d'altri luoghi ſimili: e ſi conoſcerà ancho dalle herbe, che ui naſceranno, ſe eſſe ſaranno ſolite naſcere ſolamente in fermi, e ſodi terreni; & oltre à ciò ſarà ſegno di ſodo terreno, ſe eſſo per qualche graue peſo gettato in terra; non riſuonerà, ò non tremerà: il che ſi potrà conoſcere dalle carte de' tamburi meſsi per terra, ſe à quella percoſſa leggiermente mouendoſi non riſuoneranno; & dall'acqua poſta in vn vaſo, ſe non ſi mouerà. I luoghi circonuicini ancora daranno ad intendere la ſodezza, e fermezza del terreno. Ma ſe'l luogo ſarà arenoſo, ò ghiaroſo; ſi dourà auertire, ſe ſia in terra, ò ne i fiumi: percioche ſe ſarà in terra; ſi oſſeruerà quel tanto, che di ſopra è ſtato detto de' ſodi terreni. E ſe ſi fabricherà ne' fiumi; l'arena, e la ghiara ſaranno del tutto inutili: percioche l'acqua co'l continuo ſuo corſo, e con le piene uaria continouamente il ſuo letto: però ſi cauerà fin che ſi ritroui il fondo ſodo, e fermo: ouero, ſe ciò fuſſe difficile; ſi cauerà alquanto nell'arena, & ghiara, e poi ſi faranno le palificate, che arriuino con le punte de' pali di rouere nel buono, e ſodo terreno, e ſopra quelle ſi fabricherà. Ma ſe ſi ha da fabricare in terreno moſſo, e non ſodo; all'hora ſi deue cauare fin che ſi ritroui il ſodo terreno, e tanto ancho in quello, quanto richiederanno la groſſezza de' muri, e la grandezza della fabrica. Queſto ſodo terreno, & atto à ſoſtenere gli edificij è di varie ſorti: percioche (come ben dice l'Alberti) altroue è coſi duro, che quaſi il ferro non lo può tagliare; altroue più ſodo; altroue negreggia; altroue imbianca (e queſto è riputato il più debole) altroue è come creta; altroue è di tofo. Di tutti queſti quello è migliore, che à fatica ſi taglia, e quello che bagnato non ſi diſſolue in fango. Non ſi deue fondare ſopra ruina, ſe prima non ſi ſaprà, come ella ſia ſufficiente à ſoſtenere l'edificio, e quanto profondi. Ma ſe'l terreno ſarà molle, e profonderà molto, come nelle paludi; all'hora ſi faranno le palificate: i pali delle quali ſaranno lunghi per l'ottaua parte dell'altezza del muro, e groſsi per la duodecima parte della loro lunghezza. Si deono ficcare i pali ſi ſpeſsi, che fra quelli non ve ne poſſano entrar de gli altri: & deono eſſer battuti con colpi più toſto ſpeſsi, che graui, accioche meglio venga à conſolidarſi il terreno, e fermarſi. Si faranno le palificate non ſolo ſotto i muri di fuori, poſti ſopra i canali; ma ancora ſotto quelli, che ſono fra terra, e diuidono le fabriche: perche ſe ſi faranno le fondamenta a' muri di mezo, diuerſe da quelle di fuori, mettendo delle traui vna à canto dell'altra per lungo, & altre ſopra per trauerſo; ſpeſſe volte auerrà, che i muri di mezo caleranno à baſſo: e quelli di fuori per eſſer ſopra i pali; non ſi moueranno: onde tutti i muri verranno ad aprirſi: il che rende ruinoſa la fabrica, & è bruttiſimo da vedere. Però ſi ſchiferà queſto pericolo facendoſi maſsimamente minore ſpeſa nelle palificate: perche ſecondo la proportione de' muri, coſi dette palificate di mezo anderanno più ſottili di quelle di fuora.
E FONDAMENTA propriamente ſi dicono la baſe della fabrica, cioè quella parte, ch'è ſotto terra: laquale ſoſtenta tutto l'edificio, che ſopra terra ſi uede. Però tra tutti gli errori, ne' quali fabricando ſi può incorrere; ſono dannoſiſsimi quelli, che nelle fondamenta ſi commettono: perche apportano ſeco la rouina di tutta l'opera, nè ſi ponno ſenza grandiſsima difficultà emendare: onde l'Architetto deue ponerui ogni ſua diligenza; percioche in alcun luogo ſi hanno fondamenta dalla Natura, e altroue è biſogno vſarui l'arte. Dalla Natura habbiamo le fondamenta, quando ſi ha da fabricare ſopra il ſaſſo, toſo, e ſcaranto: ilquale è vna ſorte di terreno, che tiene in parte della pietra: percioche queſti ſenza biſogno di cauamento, ò d'altro aiuto dell'arte ſono da ſe ſteſsi buoniſsimo fondamento, & attiſsimo à ſoſtenere ogni grande edificio, coſi in terra, come ne i fiumi. Ma ſe la Natura non ſomminiſtrerà le fondamenta; ſarà di meſtieri cercarle con l'arte, & all'hora, ò ſi haurà da fabricare in terren ſodo, ouero in luogo, oue ſia ghiara, ò arena, ò terren moſſo, ò molle, e paludoſo. Se'l terren ſarà ſodo, e fermo; tanto in quello ſi cauerà ſotto, quanto parerà al giudicioſo Architetto, che richieda la qualità della fabrica, e la ſodezza di eſſo terreno. laquale cauatione per lo più farà la ſeſta parte dell'altezza dell'edificio, non uolendoui far cantine, ò altri luoghi ſotterranei. A conoſcer queſta ſodezza, giouerà l'oſſeruanza delle cauationi de' pozzi, delle ciſterne, & d'altri luoghi ſimili: e ſi conoſcerà ancho dalle herbe, che ui naſceranno, ſe eſſe ſaranno ſolite naſcere ſolamente in fermi, e ſodi terreni; & oltre à ciò ſarà ſegno di ſodo terreno, ſe eſſo per qualche graue peſo gettato in terra; non riſuonerà, ò non tremerà: il che ſi potrà conoſcere dalle carte de' tamburi meſsi per terra, ſe à quella percoſſa leggiermente mouendoſi non riſuoneranno; & dall'acqua poſta in vn vaſo, ſe non ſi mouerà. I luoghi circonuicini ancora daranno ad intendere la ſodezza, e fermezza del terreno. Ma ſe'l luogo ſarà arenoſo, ò ghiaroſo; ſi dourà auertire, ſe ſia in terra, ò ne i fiumi: percioche ſe ſarà in terra; ſi oſſeruerà quel tanto, che di ſopra è ſtato detto de' ſodi terreni. E ſe ſi fabricherà ne' fiumi; l'arena, e la ghiara ſaranno del tutto inutili: percioche l'acqua co'l continuo ſuo corſo, e con le piene uaria continouamente il ſuo letto: però ſi cauerà fin che ſi ritroui il fondo ſodo, e fermo: ouero, ſe ciò fuſſe difficile; ſi cauerà alquanto nell'arena, & ghiara, e poi ſi faranno le palificate, che arriuino con le punte de' pali di rouere nel buono, e ſodo terreno, e ſopra quelle ſi fabricherà. Ma ſe ſi ha da fabricare in terreno moſſo, e non ſodo; all'hora ſi deue cauare fin che ſi ritroui il ſodo terreno, e tanto ancho in quello, quanto richiederanno la groſſezza de' muri, e la grandezza della fabrica. Queſto ſodo terreno, & atto à ſoſtenere gli edificij è di varie ſorti: percioche (come ben dice l'Alberti) altroue è coſi duro, che quaſi il ferro non lo può tagliare; altroue più ſodo; altroue negreggia; altroue imbianca (e queſto è riputato il più debole) altroue è come creta; altroue è di tofo. Di tutti queſti quello è migliore, che à fatica ſi taglia, e quello che bagnato non ſi diſſolue in fango. Non ſi deue fondare ſopra ruina, ſe prima non ſi ſaprà, come ella ſia ſufficiente à ſoſtenere l'edificio, e quanto profondi. Ma ſe'l terreno ſarà molle, e profonderà molto, come nelle paludi; all'hora ſi faranno le palificate: i pali delle quali ſaranno lunghi per l'ottaua parte dell'altezza del muro, e groſsi per la duodecima parte della loro lunghezza. Si deono ficcare i pali ſi ſpeſsi, che fra quelli non ve ne poſſano entrar de gli altri: & deono eſſer battuti con colpi più toſto ſpeſsi, che graui, accioche meglio venga à conſolidarſi il terreno, e fermarſi. Si faranno le palificate non ſolo ſotto i muri di fuori, poſti ſopra i canali; ma ancora ſotto quelli, che ſono fra terra, e diuidono le fabriche: perche ſe ſi faranno le fondamenta a' muri di mezo, diuerſe da quelle di fuori, mettendo delle traui vna à canto dell'altra per lungo, & altre ſopra per trauerſo; ſpeſſe volte auerrà, che i muri di mezo caleranno à baſſo: e quelli di fuori per eſſer ſopra i pali; non ſi moueranno: onde tutti i muri verranno ad aprirſi: il che rende ruinoſa la fabrica, & è bruttiſimo da vedere. Però ſi ſchiferà queſto pericolo facendoſi maſsimamente minore ſpeſa nelle palificate: perche ſecondo la proportione de' muri, coſi dette palificate di mezo anderanno più ſottili di quelle di fuora.
DELLE FONDAMENTA. Cap. VIII.
 EONO eſſere le fondamenta il doppio più groſſe del muro, c'ha da eſſerui poſto ſopra: & in queſto ſi douerà hauer riguardo alla qualità del terreno, & alla grandezza dell'edificio, facendole ancho più larghe ne' terreni moſsi, e men ſodi, e doue haueſſero da ſoſtentare grandiſsimo carico. Il piano della foſſa deue eſſere vguale: accioche il peſo prema vgualmente, e non venendo à calare in vna parte più che nell'altra, i muri ſi aprano. Per queſta cagione laſtricauano gli Antichi il detto piano di Teuertino, e noi ſiamo ſoliti à ponerui delle tauole, ouero delle traui, e ſopra di quelle poi fabricare. Si fanno le fondamenta à ſcarpa, cioè che tanto più decreſcano, quanto piu s'inalzano; in modo però, che tanto da una parte ſia laſciato, quanto dall'altra, onde il mezo di quel di ſopra caſchi à piombo al mezo di quel di ſotto: il che ſi deue oſſeruare ancho nelle diminutioni de' muri ſopra terra: percioche in queſto modo la fabrica uiene ad hauere molto maggior fortezza, che facendoſi le diminutioni altramente. Si fanno alcuna uolta (maſsimamente ne i terreni paludoſi, doue interuengano colonne) per far minore ſpeſa le fondamenta non continouate, ma con alcuni volti, e ſopra quelli poi ſi fabrica. Sono aſſai lodeuoli nelle fabriche grandi alcuni ſpiragli per la groſſezza del muro dalle fondamenta ſino al tetto, percioche danno eſito a' venti, che meno diano noia alla fabrica, ſcemano la ſpeſa, e ſono, di non picciola commodità, ſe in quelli ſi faranno ſcale à lumaca: le quali portino dal fondamento fino al ſommo dell'edificio.
EONO eſſere le fondamenta il doppio più groſſe del muro, c'ha da eſſerui poſto ſopra: & in queſto ſi douerà hauer riguardo alla qualità del terreno, & alla grandezza dell'edificio, facendole ancho più larghe ne' terreni moſsi, e men ſodi, e doue haueſſero da ſoſtentare grandiſsimo carico. Il piano della foſſa deue eſſere vguale: accioche il peſo prema vgualmente, e non venendo à calare in vna parte più che nell'altra, i muri ſi aprano. Per queſta cagione laſtricauano gli Antichi il detto piano di Teuertino, e noi ſiamo ſoliti à ponerui delle tauole, ouero delle traui, e ſopra di quelle poi fabricare. Si fanno le fondamenta à ſcarpa, cioè che tanto più decreſcano, quanto piu s'inalzano; in modo però, che tanto da una parte ſia laſciato, quanto dall'altra, onde il mezo di quel di ſopra caſchi à piombo al mezo di quel di ſotto: il che ſi deue oſſeruare ancho nelle diminutioni de' muri ſopra terra: percioche in queſto modo la fabrica uiene ad hauere molto maggior fortezza, che facendoſi le diminutioni altramente. Si fanno alcuna uolta (maſsimamente ne i terreni paludoſi, doue interuengano colonne) per far minore ſpeſa le fondamenta non continouate, ma con alcuni volti, e ſopra quelli poi ſi fabrica. Sono aſſai lodeuoli nelle fabriche grandi alcuni ſpiragli per la groſſezza del muro dalle fondamenta ſino al tetto, percioche danno eſito a' venti, che meno diano noia alla fabrica, ſcemano la ſpeſa, e ſono, di non picciola commodità, ſe in quelli ſi faranno ſcale à lumaca: le quali portino dal fondamento fino al ſommo dell'edificio.
DELLE MANIERE DE' MVRI. Cap. IX.
 ATTE le fondamenta; reſta che trattiamo del muro diritto ſopra terra. Sei appreſſo gli Antichi furono le maniere de' muri; l'vna detta reticolata, l'altra di terra cotta, ò quadrello: la terza di cementi, cioè di pietre roze di montagna, ò di fiume: la quarta di pietre incerte: la quinta di ſaſſo quadrato: e la ſeſta la riempiuta. Della reticolata a' noſtri tempi non ſe ne ſerue alcuno: ma perche Vitruuio dice, che a' ſuoi tempi communemente ſi vſaua; ho voluto porre ancho di queſta il diſegno. Faceuano gli angoli, ouer cantoni della fabrica di pietra cotta, & ogni due piedi e mezo tirauano tre corſi di quadrello; i quali legauano tutta la groſſezza del muro.
ATTE le fondamenta; reſta che trattiamo del muro diritto ſopra terra. Sei appreſſo gli Antichi furono le maniere de' muri; l'vna detta reticolata, l'altra di terra cotta, ò quadrello: la terza di cementi, cioè di pietre roze di montagna, ò di fiume: la quarta di pietre incerte: la quinta di ſaſſo quadrato: e la ſeſta la riempiuta. Della reticolata a' noſtri tempi non ſe ne ſerue alcuno: ma perche Vitruuio dice, che a' ſuoi tempi communemente ſi vſaua; ho voluto porre ancho di queſta il diſegno. Faceuano gli angoli, ouer cantoni della fabrica di pietra cotta, & ogni due piedi e mezo tirauano tre corſi di quadrello; i quali legauano tutta la groſſezza del muro.
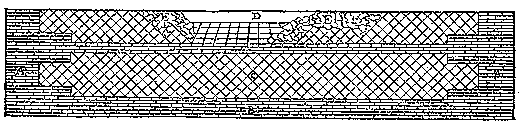
A, Cantonate fatte di quadrello.
B, Corſi di quadrello che legano tutto il muro.
C, Opera reticolata.
D, Corſi de i quadrelli per la groſſezza del muro.
E, Parte di mezo del muro fatta di cementi.
I muri di pietra cotta nelle muraglie della Città, ò in altri molto grandi edificij ſi debbono fare, che nella parte di dentro, & in quella di fuori ſiano di quadrello, e nel mezo pieni di cementi inſieme co'l copo peſto; e che ogni tre piedi di altezza ui ſiano tre corſi di quadrelli maggiori de gli altri, che piglino tutta la larghezza del muro: & il primo corſo ſia in chiaue, cioè che ſi vegga il lato minore del quadrello, il ſecondo per lungo, cioè co'l lato maggiore di fuori, & il terzo in chiaue. Di queſta maniera ſono in Roma i muri della Ritonda, e delle Terme di Dioclitiano, & di tutti gli Edificij antichi che vi ſono.
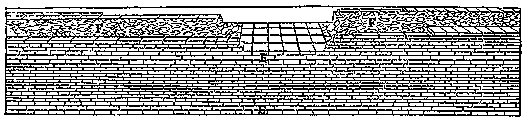
E, Corſi di quadrelli che legano tutto il muro.
F, Parte di mezo del muro fatta di cementi fra l'vn corſo e l'altro & i quadrelli eſteriori.
I muri di cementi ſi faranno, che ogni due piedi al meno vi ſiano tre corſi di pietra cotta, e ſiano le pietre cotte ordinate al modo detto di ſopra. Coſi in Piemonte ſono le mura di Turino, lequali ſono fatte di cuocoli di fiume tutti ſpezzati nel mezo, e ſono detti cuocoli poſti con la parte ſpezzata in fuori, onde fanno drittiſsimo, e politiſsimo lauoro. I muri dell'Arena di Verona ſono anch'eſsi di cementi, & ogni tre piedi vi ſono tre corſi di quadrelli; e coſi ſono fatti ancho altri edificij, come ſi potrà vedere ne' miei libri dell'Antichità.
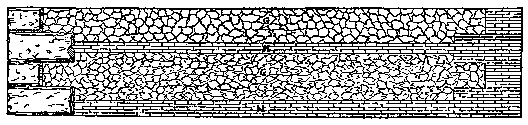
G, Cementi, ò cuocoli di fiume.
H, Corſi di quadrelli che legano tutto il muro.
Di pietre incerte ſi diceuano quei muri, ch'erano fatti di pietre diſuguali di angoli, e lati: & à far queſti muri vſauano vna ſquadra di piombo, la qual piegata ſecondo il luogo, doue douea eſſer poſta la pietra; ſeruiua loro nello ſquadrarla: e ciò faceuano accioche le pietre cômetteſſero bene inſieme, e per nô hauer da prouare più, e più volte ſe la pietra ſtaua bene al luogo, oue eſsi haueuano diſegnato di porla. Di queſta maniera ſi veggono muri à Preneſte; e le ſtrade antiche ſono in queſto modo laſtricate.
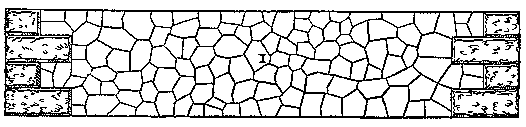
I, Pietre incerte.
Di pietre quadrate muri ſi veggono in Roma, oue era la piazza, & il Tempio di Auguſto: ne' quali inchiauauano le pietre minori con alcuni corſi di pietre maggiori.
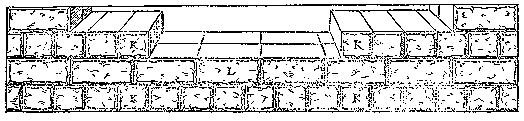
k, Corſi di pietre minori.
L, Corſi di pietre maggiori.
La maniera riempiuta, che ſi dice ancho à caſſa, faceuano gli Antichi pigliando con tauole poſte in coltello tanto ſpacio, quanto voleuano che fuſſe groſſo il muro, empiendolo di malta, e di pietre di qualunque ſorte meſcolate inſieme, e coſi andauano facendo di corſo in corſo. Si veggono muri di queſta ſorte à Sirmion ſopra il Lago di Garda.
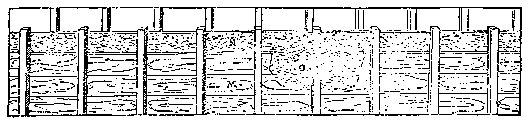
M, Tauole poſte in coltello.
N, Parte di dentro del muro.
O, Faccia del muro tolte via le tauole.
Di queſta maniera ſi poſſono ancho dire le mura di Napoli, cioè le Antiche: le quali hanno due muri di ſaſſo quadrato groſsi quattro piedi, e diſtanti tra ſe piedi ſei. Sono legati inſieme queſti muri da altri muri per trauerſo, e le caſſe, che rimangono fra detti trauerſi, & muri eſteriori ſono ſei piedi per quadro, e ſono empiute di ſaſsi e di terra.
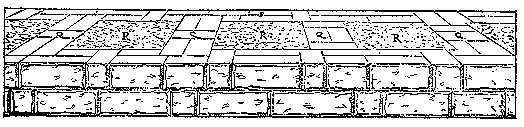
P, Muri di pietra eſteriori.
Q, Muri di pietra poſti per trauerſo.
R, Caſſe piene di pietre, e di terra.
Queſte in ſomma ſono le maniere, delle quali ſi ſeruirono gli Antichi, & hora ſi ueggono i veſtigi: dalle quali ſi comprende che ne i muri di qualunque ſorte ſi ſiano, debbono farſi alcuni corſi, i quali ſiano come nerui, che tengano inſieme legate le altre parti; ilche maſsimamente ſi oſſeruerà, quando ſi faranno i muri di pietre cotte; accioche per la vecchiezza venendo a calare in parte la ſtruttura di mezo; non diuentino i muri ruinoſi, come è occorſo, & ſi vede in molte mura da quella parte ſpecialmente ch'è riuolta à Tramontana.
DEL MODO CHE TENEVANO GLI ANTICHI NEL FAR
gli edificij di pietra. Cap. X.
 ERCHE alcuna volta occorre che la fabrica tutta, ò buona parte ſi faccia di marmo, ò di pezzi grandi d'altra pietra; mi pare conueneuole in queſto luogo dire come in tal caſo faceuano gli Antichi: perche ſi vede nell'opere loro eſſere ſtata vſata tanta diligenza nel congiungere inſieme le pietre, che in molti luoghi à pena ſi diſcernono le commeſſure: alche deue molto auuertire chi oltre la bellezza deſidera la fermezza, e perpetuità della fabrica. E per quanto ho potuto côprendere; eſsi prima ſquadrauano, e lauorauano delle pietre quelle faccie ſolamente che andauano vna ſopra l'altra, laſſando l'altre parti roze; e coſi lauorate le metteuano in opera; onde perche tutti gli orli delle pietre veniuano ad eſſer ſopra ſquadra, cioè groſsi, e ſodi; poteuano meglio maneggiarle, e mouerle più uolte fin che cômetteſſero bene, ſenza pericolo di rôperli, che ſe tutte le faccie fuſſero ſtate lauorate; perche all'hora ſarebbono ſtati gli orli ò à ſquadra, ò ſotto ſquadra, e coſi molto deboli, e facili da guaſtarſi: & in queſto modo faceuano tutti gli edificij rozi, ò uogliam dire ruſtichi: & eſſendo poi quelli finiti, andauano lauorando, e polendo delle pietre (come ho detto) già meſſe in opera, quelle faccie, ch'andauano vedute. E` ben vero, che, come le roſe, che andauano tra i modiglioni, & altri intagli della cornice, che cômodamente non poteuano farſi, eſſendo le pietre in opera; faceuano mentre che quelle erano ancora in terra. Di ciò ottimo indicio ſono diuerſi edificij antichi: ne' quali ſi veggono molte pietre, che non furono finite di lauorare, e polire. L'Arco appreſſo Caſtel vecchio in Verona, e tutti quegli altri Archi, & edificij che vi ſono furono fatti nel detto modo: il che molto bene conoſcerà chi auertirà a' colpi de' martelli, cioè come le pietre vi ſiano lauorate. La colonna Traiana in Roma, e l'Antonina ſimilmête furono fatte, nè altramente s'haurebbono potuto côgiungere coſi diligentemête le pietre, che coſi bene s'incontraſſero le commeſſure; lequali vanno à trauerſo le teſte, & altre parti delle figure; e il medeſimo dico di quegli Archi che vi ſi veggono. E s'era qualche edificio molto grâde, com'è l'Arena di Verona, l'Anfitheatro di Pola, e ſimili, per fuggir la ſpeſa e tempo, che vi ſarebbe andato; lauorauano ſolamente l'impoſte de' volti, i capitelli, e le cornici, & il reſto laſciauano ruſtico, tenendo ſolamente conto della bella forma dell'edificio. Ma ne' Tempij, & ne gli altri edificij, che richiedeuano delicatezza, nô riſparmiauano fatica nel lauorarli tutti, e nel fregare, e liſciare fino i canali delle colonne, & polirli diligentemête. Però per mio giudicio nô ſi farâno muri di pietra cotta ruſtichi, nè meno le Nappe de' Camini: lequali deono eſſer fatte delicatiſsime: percioche oltra l'abuſo, ne ſeguirà, che ſi fingerà ſpezzato, e diuiſo in più parti quello, che naturalmente deue eſſere intiero: Ma ſecondo la grandezza, e qualità della fabrica, ſi farà ò ruſtica, ò polita; e non quello che gli antichi fecero, neceſsitati dalla grandezza delle opere, & giudicioſamête; faremo noi in vna fabrica, alla quale ſi ricerchi al tutto la politezza.
ERCHE alcuna volta occorre che la fabrica tutta, ò buona parte ſi faccia di marmo, ò di pezzi grandi d'altra pietra; mi pare conueneuole in queſto luogo dire come in tal caſo faceuano gli Antichi: perche ſi vede nell'opere loro eſſere ſtata vſata tanta diligenza nel congiungere inſieme le pietre, che in molti luoghi à pena ſi diſcernono le commeſſure: alche deue molto auuertire chi oltre la bellezza deſidera la fermezza, e perpetuità della fabrica. E per quanto ho potuto côprendere; eſsi prima ſquadrauano, e lauorauano delle pietre quelle faccie ſolamente che andauano vna ſopra l'altra, laſſando l'altre parti roze; e coſi lauorate le metteuano in opera; onde perche tutti gli orli delle pietre veniuano ad eſſer ſopra ſquadra, cioè groſsi, e ſodi; poteuano meglio maneggiarle, e mouerle più uolte fin che cômetteſſero bene, ſenza pericolo di rôperli, che ſe tutte le faccie fuſſero ſtate lauorate; perche all'hora ſarebbono ſtati gli orli ò à ſquadra, ò ſotto ſquadra, e coſi molto deboli, e facili da guaſtarſi: & in queſto modo faceuano tutti gli edificij rozi, ò uogliam dire ruſtichi: & eſſendo poi quelli finiti, andauano lauorando, e polendo delle pietre (come ho detto) già meſſe in opera, quelle faccie, ch'andauano vedute. E` ben vero, che, come le roſe, che andauano tra i modiglioni, & altri intagli della cornice, che cômodamente non poteuano farſi, eſſendo le pietre in opera; faceuano mentre che quelle erano ancora in terra. Di ciò ottimo indicio ſono diuerſi edificij antichi: ne' quali ſi veggono molte pietre, che non furono finite di lauorare, e polire. L'Arco appreſſo Caſtel vecchio in Verona, e tutti quegli altri Archi, & edificij che vi ſono furono fatti nel detto modo: il che molto bene conoſcerà chi auertirà a' colpi de' martelli, cioè come le pietre vi ſiano lauorate. La colonna Traiana in Roma, e l'Antonina ſimilmête furono fatte, nè altramente s'haurebbono potuto côgiungere coſi diligentemête le pietre, che coſi bene s'incontraſſero le commeſſure; lequali vanno à trauerſo le teſte, & altre parti delle figure; e il medeſimo dico di quegli Archi che vi ſi veggono. E s'era qualche edificio molto grâde, com'è l'Arena di Verona, l'Anfitheatro di Pola, e ſimili, per fuggir la ſpeſa e tempo, che vi ſarebbe andato; lauorauano ſolamente l'impoſte de' volti, i capitelli, e le cornici, & il reſto laſciauano ruſtico, tenendo ſolamente conto della bella forma dell'edificio. Ma ne' Tempij, & ne gli altri edificij, che richiedeuano delicatezza, nô riſparmiauano fatica nel lauorarli tutti, e nel fregare, e liſciare fino i canali delle colonne, & polirli diligentemête. Però per mio giudicio nô ſi farâno muri di pietra cotta ruſtichi, nè meno le Nappe de' Camini: lequali deono eſſer fatte delicatiſsime: percioche oltra l'abuſo, ne ſeguirà, che ſi fingerà ſpezzato, e diuiſo in più parti quello, che naturalmente deue eſſere intiero: Ma ſecondo la grandezza, e qualità della fabrica, ſi farà ò ruſtica, ò polita; e non quello che gli antichi fecero, neceſsitati dalla grandezza delle opere, & giudicioſamête; faremo noi in vna fabrica, alla quale ſi ricerchi al tutto la politezza.